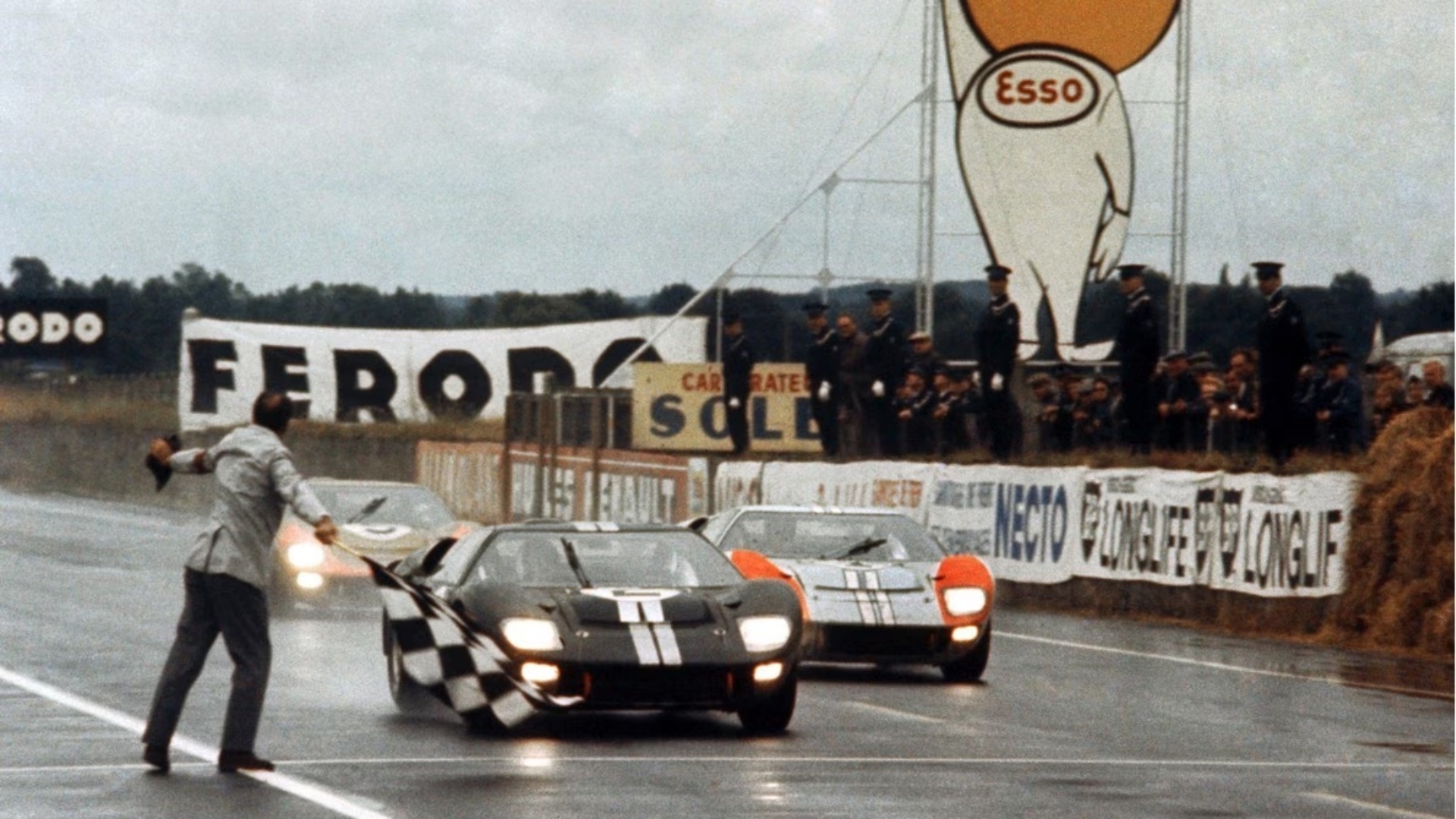NEWS
Jeep: alla guida delle storiche
05 aprile 2016
Abbiamo guidato alcune delle più rappresentative fuoristrada della Jeep: dal modello originale, la Willys-Overland MB, alla prima Grand Cherokee.
Abbiamo guidato alcune delle più rappresentative fuoristrada della Jeep: dal modello originale, la Willys-Overland MB, alla prima Grand Cherokee.
ANCORA NON JEEP - La nascita del marchio Jeep viene fatta coincidere con il 1941, quando esce dalle catene di montaggio il primo esemplare della Willys-Overland MB: è una spartana scoperta pensata per rimpiazzare moto e muli nell'esercito e tutte le sue caratteristiche sono in funzione di ciò. Il parabrezza, ad esempio, deve essere abbattibile per consentire la spedizione dentro pratiche casse di legno e la meccanica è robusta e semplice. Le linee sono squadrate e saranno di ispirazione per le numerose eredi con il marchio Jeep: passaruota lineari, ben staccati dalla carrozzeria, assenza di porte e cofano piatto, giusto arrotondato ai bordi.

LA PRODUSSE ANCHE LA FORD - Quella che abbiamo davanti è, come le altre che guideremo, un esemplare perfettamente restaurato di proprietà della casa americana, portato nello Utah per una serie di celebrazioni dei 75 anni del marchio. Che sia una delle 368.000 prodotte dalla Willys-Overland (foto qui sopra) e non una delle 277.000 costruite su licenza da Ford lo si capisce per l'assenza di una piccola "F" stampata su ciascuno dei componenti. Salire a bordo non richiede particolare agilità, dato che le porte sono assenti e la soglia è relativamente bassa da terra, ma c'è da scivolare con le gambe sotto il grande e sottile volante, posto molto vicino allo schienale. Protetti dal sole da un sottile telo teso sopra la testa, la prima cosa che si nota è il portafucili fissato alla base del parabrezza, appena dietro la corona. Inutile sperare in qualcosa di ergonomico: duro metallo a vista, sedili piatti e indicatori messi in posizione centrale e molto in basso (ma, tanto, chi è che in guerra controlla il tachimetro?).
ANCORA GAGLIARDA - Per dar vita al quattro cilindri a benzina 2.2 da "ben" 60 cavalli, si ruota un interruttore e si preme con il tallone destro l'acceleratore e contemporaneamente un bottone davanti alla leva del cambio con la punta dello stesso piede. Il peso della Willys-Overland inferiore alla tonnellata, a dispetto del robusto telaio a longheroni, permette alla MB di accelerare con una certa rapidità ma difficilmente qualcuno potrebbe voler correre con questa "vecchietta": lo sterzo è molto demoltiplicato e le molle a balestra fanno rimbalzare già a bassa velocità ogni volta si incontra un minimo ostacolo: sono fatte per essere “strapazzate” sui terreni più impervi, non per essere comode. Essere però alla guida di una delle vetture che ha fatto la storia non ha prezzo e la regolarità d'erogazione permette di marciare anche a passo d'uomo senza sussulti. Certo, inserire le marce (tre, più la retromarcia) richiede precisione e decisione, agendo sulla lunga e sottile asta che sbuca dal pavimento, mentre per frenare c'è da premere con molta forza sul pedale centrale: sulla Willys niente è servoassistito.

SETTE FERITOIE? PER CASO - Finita la Seconda Guerra Mondiale, molti militari americani acquistarono per l'uso civile le MB che avevano guidato in Europa, Asia e Africa. La cosa non passò inosservata all'azienda che, nel 1945, propose una versione "senza divisa" della MB, la CJ-2A (da “Civilian Jeep”, ovvero “Jeep civile", foto qui sopra). Ancora, però, sulle lamiere è stampato il marchio Willys: quello attuale arriverà solo negli anni 50. Persino l'origine del nome è incerta: Jeep potrebbe derivare dalla trascrizione fonetica della sigla GP (General Purpose, ovvero "uso generico", che contraddistingueva alcuni prototipi militari di questo veicolo) come da Eugene the Jeep, un personaggio dei fumetti di Braccio di Ferro che in Italia è conosciuto come Eugenio il Gip. Praticamente identica nelle caratteristiche tecniche (e da guidare), la CJ-2A è importante anche per un altro motivo: è stata la prima vettura del marchio ad avere la griglia con sette feritoie. Il motivo? Per l'omologazione stradale erano richiesti fari più grandi di quelli della MB e, per far loro posto, vennero tolte le due più esterne. Oggi troviamo i sette "tagli" nel frontale su tutte le Jeep, ma questa tradizione è iniziata solo nel 1998.
LA PRIMA "DI LUSSO" - Se la CJ-2A era essenzialmente un mezzo da lavoro, con la Willys Wagon del 1946 si cambia "musica": se la meccanica è strettamente imparentata, la carrozzeria è chiusa, i posti ben sette e i vetri ampi. Ad aprire le porte dell'esemplare del 1949 (il primo anno in cui fu prodotta anche 4x4) davanti a noi, stupisce quanto siano sottili. La colorazione in due toni di marrone delle fiancate, poi, la fa sembrare molto più antiquata di concezione delle altre Willys ma, in realtà, la Wagon fu il primo veicolo non commerciale ad usare una carrozzeria totalmente in acciaio: lo schema di colori fu scelto solo per ricordare il legno e non scioccare i clienti del tempo, che erano abituati alle vetture con questo materiale a vista. Con incedere un po' traballante e qualche "profumo" di gas di scarico nell'abitacolo, la Wagon si lascia condurre per le lisce strade dello stato americano: la visibilità è ottima, ma manca quel senso di libertà che solo le Jeep aperte sanno dare. Le prestazioni? "Adeguate".

TANTI CILINDRI, POCHI CAVALLI - In color senape e con vistosi freni a tamburo cromati che fanno parte dei cerchi: così si presenta la CJ-5 del 1973 (foto qui sopra) che ci troviamo a guidare dopo poco. "Imborghesita" (per modo di dire) rispetto alla CJ-2A (rispetto alle quali è anche più grande e spaziosa) grazie ai passaruota stondati, questa è una delle Jeep più amate e longeve: fra il 1955 e il 1983 fu prodotta in oltre 600.000 esemplari. Sulla ribaltina il nome "Jeep" è ora ben evidente: venne introdotto ufficialmente nel 1953 quando la Willys-Overland si fuse con la Kaiser-Frazer per dare vita alla Kaiser-Jeep. La scritta V8 sulla fiancata fa ben capire che tipo di motore ci sia sotto il cofano. A dispetto dei 5 litri di cilindrata, però, i cavalli non sono più di 150 (qualcuno di più, secondo i metodi attuali di misurazione): abbastanza per accelerare con un bel brio, mettendo magari mano al cambio manuale piuttosto preciso (per il tipo di veicolo), e godersi su strada il "borbottio" tipico di questa architettura ai bassi giri. Invidiabile la visibilità, ora non più "sporcata" dal parabrezza in due pezzi.

SOTTO CAMBIA TUTTO - Se finora abbiamo guidato modelli che sono poco più che evoluzioni della prima Willys, con la Cherokee del 1974 (foto qui sopra) si cambia. Le linee sono molto diverse da quelle delle precedenti Jeep (niente passaruota separati dal cofano e una larga griglia con ben 14 feritoie) e anche la spartanità è un lontano ricordo, sebbene l'auto non sia certo nata con l'idea del lusso: i sedili sono ampi, piatti e molto soffici, è presente un ampio bracciolo centrale e non manca neppure l'aria condizionata. La plancia è sì squadrata ma con un'impostazione ancora attuale: sviluppo orizzontale e cruscotto dietro al sottile volante (in plastica stampata, che vuole imitare il disegno di pelle e impunture); non manca neppure un piccolo orologio al quarzo con cifre verdi, che agli inizi degli anni 80 "gridava modernità". Scaldato dal sole, il vinile dell'abitacolo rilascia un odore che chi ha a che fare con le auto d'epoca ben conosce e, quando giriamo la chiave d'avviamento sul sottile piantone dello sterzo, la Cherokee si mette in moto con un bel timbro regolare. In marcia, lo sterzo è tanto leggero da sembrare scollegato dalle ruote ma, grazie alla servoassistenza, si è potuto renderlo un po' più diretto di quello della CJ-5. Da dietro il parabrezza, si vede quasi solo il lungo cofano che, in queste strade infinite, punta deciso verso l'orizzone: cullati dalle sospensioni tutt'altro che ferme, si potrebbe guidare per chilometri senza stancarsi.

RIVOLUZIONE... LENTA - La stessa impostazione la ritroviamo nella squadrata Cherokee della generazione XJ: quando uscì nel 1984 (nella foto qui sopra, lo stesso anno del nostro rosso esemplare) fu una mezza rivoluzione. Per la prima volta, infatti, una Jeep non aveva un telaio a longheroni separato dalla carrozzeria ma una struttura autoportante, saldata a degli elementi aggiuntivi di rinforzo pensati per dare maggiore rigidità nel fuori strada. Sebbene la vettura fosse totalmente nuova, l'impostazione dell'abitacolo è pressoché la stessa di quella delle precedenti Cherokee, magari con qualche centimetro in meno a causa delle porte più spesse. Plastica, moquette e vinile abbondano e anche lo sterzo è leggero come una piuma. Rispetto ai parametri attuali, la guida è tutt'altro che precisa e stupisce la fiacchezza del 2.8 V6 a benzina: con i suoi 115 cavalli è decisamente sottodimensionato e sentiamo che anche la più lenta delle citycar potrebbe batterci in accelerazione. A dispetto di questo, però, la XJ continua ad avere fascino e lo testimonia il seguito che questa vettura ha fra chi fa fuori strada "impegnato", grazie alla sua robustezza (specialmente con il 4.0 V8 a benzina o, in Europa, il 2.5 a gasolio: entrambi più ricchi di coppia).
LINEE DI ROTTURA - Se la XJ fu rivoluzionaria per le soluzioni tecniche, la Grand Cherokee del 1993 lo fu per il design: linee più arrotondate, assenza di cromature e superfici raccordate fra loro con dolcezza. A bordo di questo esemplare bianco, però, c'è ancora "aria di casa": pedali, volante, leve e pedali si trovano nella stessa posizione di quelli della Cherokee di dieci anni più vecchia e anche lo spazio, abbondante, è circa lo stesso. Il massiccio volante con airbag (quest'auto fu la prima suv a montarlo) ci ricorda quanto questi fossero sgraziati alla loro introduzione, prima che la tecnologia riducesse le dimensioni del "cuscini". Il 5.2 V8, il più americano dei motori, ha un bel rombo e dimostra anche qualcosa in più dei suoi 220 CV; solo la tendenza della carrozzeria a inclinarsi in curva e la lentezza del cambio automatico consigliano di "alzare il piede". Quello che conta su un'auto del genere (la prima suv davvero di lusso della casa), però, è il comfort e questo ancora oggi rimane di alto livello.
TI PIACE QUEST'AUTO?
Entra o
registrati per votare
I VOTI DEGLI UTENTI
VOTO MEDIO
3,4
921
Aggiungi un commento

Fr4ncesco
5 aprile 2016 - 16:40
La versione Ford del Willys è riconoscibile anche dalle bande orizzontali anzichè verticali.
- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

ForzaPisa
5 aprile 2016 - 20:02
Veramente le Ford GPW erano (anche?) con le barre verticali...
http://www.classicmilitaryautomotive.com/vehicles-for-sale/jeeps/1943-ford-gpw-jeep-20500/
- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

Fr4ncesco
5 aprile 2016 - 21:06
La prima serie sì, aveva le barre verticali, la seconda serie del Willys della Ford (M151) aveva le barre orizzontali.
- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

ForzaPisa
5 aprile 2016 - 22:40
Ah, ok: ma quella mi pare una prima generazione ;)
Cmq grazie della info: non lo sapevo
- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

Fr4ncesco
6 aprile 2016 - 00:18
Sisi, quello nell'articolo è la prima generazione, però la Ford il secondo l'ha prodotto con le barre trasversali proprio per distinguerlo da quello prodotto dalla Jeep... Di nulla comunque, un saluto!
- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso

caronte
11 aprile 2016 - 08:57
Sono tutte bellissime.
- Accedi o registrati per inserire commenti.
- segnala abuso